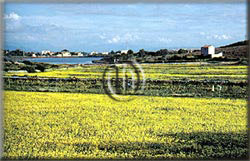|

> Isola > L'ambiente naturale

|
|
 |
Prime catalogazioni e testimonianze storiche
|
 |
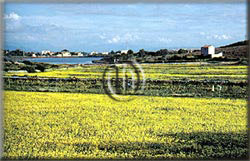
 “Quest’isola vien ad essere di 28 miglia di circuito in forma “Quest’isola vien ad essere di 28 miglia di circuito in forma
 di parallelogrammo con due capi d’erte balze che di parallelogrammo con due capi d’erte balze che
 piombano sul
lido nominati li spalmatori… Si trova a sei piombano sul
lido nominati li spalmatori… Si trova a sei
 miglia distante da
quella di Sant’Antiogo. Ella è assai miglia distante da
quella di Sant’Antiogo. Ella è assai
 montuosa di bellissimo
aspetto con spaziose valli e montuosa di bellissimo
aspetto con spaziose valli e
 pianure verdeggianti… Ricca
d’alberi d’ogni genere però pianure verdeggianti… Ricca
d’alberi d’ogni genere però
 selvatici, e molto buoni per il
servizio dell’artiglieria, non selvatici, e molto buoni per il
servizio dell’artiglieria, non
 viene abitata da alcuna persona
ma bensì da una infinità viene abitata da alcuna persona
ma bensì da una infinità
 d’animali selvatici come mofloni, caproni, cavalli, lapini
e d’animali selvatici come mofloni, caproni, cavalli, lapini
e
 lepri
abbondantissimamente… Sopra la costa si vedono le lepri
abbondantissimamente… Sopra la costa si vedono le
 vestigia
di una vecchia cappella dedicata al medesimo vestigia
di una vecchia cappella dedicata al medesimo
 Santo
alquanto elevata sopra un ponticello”. Santo
alquanto elevata sopra un ponticello”.
A queste
osservazioni dei funzionari del Regno di Sardegna, nei primi
anni del 1700, si aggiungono tutte le altre notizie e
descrizioni che studiosi, viaggiatori e naturalisti fecero
della Sardegna e dell’Isola di San Pietro tra il XVIII e il
XIX secolo. Uno dei primi osservatori fu il
gesuita Francesco
Cetti, insegnante presso l’Università di Sassari, che tra il
1772 e il 1774 realizzò un’opera in quattro volumi sulla vita
animale della Sardegna, all’interno della quale compaiono
alcune straordinarie pagine sull’isola di San Pietro.
Fu poi il
generale La Marmora che, esplorando per più di trent’anni
l’isola tra il 1819 e il 1885, elaborò una grande quantità di
notizie analitiche sulla natura della Sardegna raccolte in
quattro volumi dal titolo
Viaggio in Sardegna.
Segnalò
la presenza sull’isola di San Pietro del
falco grillaio,
della foca monaca
, del gatto selvatico e
della volpe, precisando peraltro che quest’ultima era
stata importata dall’uomo, del coniglio
e della martora.
Scoprì tra
l’altro una nuova specie di falco:
“Questa specie pare
 nuova per la scienza; il mio collega prof. Giuseppe Genè a cui
ho nuova per la scienza; il mio collega prof. Giuseppe Genè a cui
ho
 consegnato questi uccelli, ha letto all’Accademia di
Scienze di Torino consegnato questi uccelli, ha letto all’Accademia di
Scienze di Torino
 nella seduta del 5/5/1834 la prima
descrizione di questo falco per cui nella seduta del 5/5/1834 la prima
descrizione di questo falco per cui
 propone il nome di Falco Eleonorae” e individuò la presenza abbondante della
Pinna nobilis
dal cui filamento si otteneva il bisso per
la fabbricazione di scialli, cappelli e soprattutto guanti. propone il nome di Falco Eleonorae” e individuò la presenza abbondante della
Pinna nobilis
dal cui filamento si otteneva il bisso per
la fabbricazione di scialli, cappelli e soprattutto guanti.
L’isola di
San Pietro fu pure visitata dal botanico torinese
Giacinto Moris che, nella sua monumentale opera del 1858
Flora
Sardoa sulla storia delle piante in Sardegna e isole
adiacenti, segnalò come specie spontanea a
San Pietro il pino d'Aleppo:
“…
 L’isola di San Pietro, di circa 16 miglia
quadrate, presenta un ammasso L’isola di San Pietro, di circa 16 miglia
quadrate, presenta un ammasso
 di scogliere scoscese, di aspre
collinette disseminate di cespugli e di di scogliere scoscese, di aspre
collinette disseminate di cespugli e di
 boschetti di pini che
servono alla costruzione delle barche…”. Lo stesso Moris
indicò come specie nuova
astragalo marittimo Moris
un paleoendemismo relitto, una piccola pianta erbacea che vive
esclusivamente sull’isola di San Pietro; la pianta fu scoperta boschetti di pini che
servono alla costruzione delle barche…”. Lo stesso Moris
indicò come specie nuova
astragalo marittimo Moris
un paleoendemismo relitto, una piccola pianta erbacea che vive
esclusivamente sull’isola di San Pietro; la pianta fu scoperta
 nel mese di gennaio (1927), priva perciò di infiorescenze,
assieme ad alcuni semi rinvenuti nel terreno; ciò impedì al Moris di farne una descrizione completa e approfondita. Dopo
la segnalazione del Moris non fu più rinvenuto nessun
esemplare, anche perché l’ubicazione fornita dallo studioso
era molto vaga (“in arenosis lotoreis Spalmatura de fora
insulae San Pietro januario mense…”). La vastità della
zona indicata probabilmente impedì in seguito a molti
ricercatori la riscoperta dell’Astragalus, che avvenne
invece nel 1973 durante una campagna di studi promossa dai
ricercatori De Marco e Mossa. I due studiosi individuarono una
ristretta area della zona dello Spalmatore di Fuori un
centinaio di esemplari di questa nuova e unica specie sparsi
su poche centinaia di metri quadrati. nel mese di gennaio (1927), priva perciò di infiorescenze,
assieme ad alcuni semi rinvenuti nel terreno; ciò impedì al Moris di farne una descrizione completa e approfondita. Dopo
la segnalazione del Moris non fu più rinvenuto nessun
esemplare, anche perché l’ubicazione fornita dallo studioso
era molto vaga (“in arenosis lotoreis Spalmatura de fora
insulae San Pietro januario mense…”). La vastità della
zona indicata probabilmente impedì in seguito a molti
ricercatori la riscoperta dell’Astragalus, che avvenne
invece nel 1973 durante una campagna di studi promossa dai
ricercatori De Marco e Mossa. I due studiosi individuarono una
ristretta area della zona dello Spalmatore di Fuori un
centinaio di esemplari di questa nuova e unica specie sparsi
su poche centinaia di metri quadrati.
Numerose
inoltre le testimonianze dei grandi viaggiatori stranieri
quali il francese Antoine Claude Valéry, gli inglesi
Henry
Smith e Charles Edwarder, le cui osservazioni, anche di natura
economica e sociale, sono di grande effetto descrittivo, come
le pagine relative alla pesca del tonno. Ricordiamo anche le
straordinarie descrizioni dell’isola e della sua gente
contenute nelle appassionanti
Cacce Sottili di
Ernst
Jünger. per finire con le
indimenticabili pagine del giornalista genovese
Giovanni Ansaldo del 1955
di cui citiamo un estratto:
 “La terza
bellezza di Carloforte è la traversata tra l’isola grande, la “La terza
bellezza di Carloforte è la traversata tra l’isola grande, la
 Sardegna dei nuraghes, e l’isola piccola detta di San Pietro
su cui Sardegna dei nuraghes, e l’isola piccola detta di San Pietro
su cui
 Carloforte si annida con le sue casettine nitide e
lucenti nel primo sole; Carloforte si annida con le sue casettine nitide e
lucenti nel primo sole;
 sul
braccio di mare che pare chiuso a mezzogiorno sul
braccio di mare che pare chiuso a mezzogiorno dall’altra isola di
dall’altra isola di
 Sant’Antioco, e la mattina si
rischiara e si imbianca, e la sera si Sant’Antioco, e la mattina si
rischiara e si imbianca, e la sera si
 inazzurra e s’incupisce. inazzurra e s’incupisce.
 E là in
fondo l’isoletta, che man mano che il vaporetto le si avvicina
appare per tutti i suoi pendii rassomigliante E là in
fondo l’isoletta, che man mano che il vaporetto le si avvicina
appare per tutti i suoi pendii rassomigliante
 ad un presepio ad un presepio
 che i cappuccini fanno in certe chiese di Genova e della
Riviera. I grandi massi trachitici tabulari che i cappuccini fanno in certe chiese di Genova e della
Riviera. I grandi massi trachitici tabulari
 che
ne costituiscono che
ne costituiscono  la massa hanno l’aria di essere fratelli di
quei fabbricati la massa hanno l’aria di essere fratelli di
quei fabbricati con la carta dipinta a picchettature con la carta dipinta a picchettature
 di
colori vari che serve di
colori vari che serve  a fare i monti del presepio. a fare i monti del presepio.
 Le macchie
di olivastri e di lentischi che si vedono coprire la parte più
alta dell’isoletta fanno sentire la loro Le macchie
di olivastri e di lentischi che si vedono coprire la parte più
alta dell’isoletta fanno sentire la loro
 parentela con le rame
di ginepro, parentela con le rame
di ginepro,  di pungitopo e di corbezzolo che un tempo i lattai
di Bavaro e di Apparizione di pungitopo e di corbezzolo che un tempo i lattai
di Bavaro e di Apparizione
 portavano giù dai monti le mattine
prima di Natale, nelle case dei propri clienti, a Genova per
mettere il verde portavano giù dai monti le mattine
prima di Natale, nelle case dei propri clienti, a Genova per
mettere il verde
 nel presepe, che altrimenti sarebbe rimasto
troppo nudo. E le casette, sparse su tutti i pendii
dell’isola, nel presepe, che altrimenti sarebbe rimasto
troppo nudo. E le casette, sparse su tutti i pendii
dell’isola,
 sembrano, da lontano, non costruite là, ma
collocate là da un “presepita” estroso e ricercatore
dell’effetto sembrano, da lontano, non costruite là, ma
collocate là da un “presepita” estroso e ricercatore
dell’effetto
 pittoresco. Finchè
poi il vaporetto si avvicina e si accosta: allora il presepe
si anima e davanti a voi si apre un pittoresco. Finchè
poi il vaporetto si avvicina e si accosta: allora il presepe
si anima e davanti a voi si apre un
 porticciolo
di riviera...”. porticciolo
di riviera...”.
Astragalo marittimo Moris
Pinna nobilis
Falco grillaio
Foca monaca
Gatto selvatico
Volpe
Martora
Coniglio
Pino d'Aleppo

|
|




 di adattamento
di adattamento
 dell'ambiente marino
dell'ambiente marino